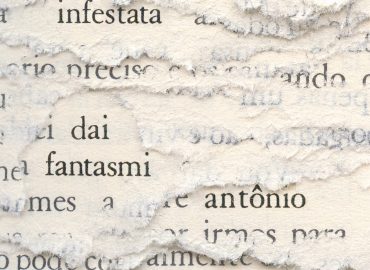Pubblichiamo la nostra intervista a Manuel Alberto Vieira, autore di Geometria della menzogna, primo titolo pubblicato da Edizioni Wordbridge.
- Ciao Manuel, prima di tutto grazie per averci dedicato del tempo per rispondere alle nostre domande. Per prima cosa vorremmo chiederti come sono nati questi racconti. Li hai creati in breve tempo o sono associati a momenti diversi della tua vita?
Sono uno scrittore abbastanza rapido, ma allo stesso tempo un revisore piuttosto lento. I racconti di questo libro in particolare sono stati scritti in un brevissimo lasso di tempo. Parlo di pochi giorni, in un processo istintivo, meccanico, vorace, come se le parole stesse mi anticipassero. Poi c’è stata una pausa. La pausa è la cosa più importante nei libri. Li lascia custoditi in un luogo che non è un luogo né un tempo esatto. Poi arriva un momento in cui i libri ti chiamano. Cominci a ricordare questa o quella frase, questa o quella idea e passi al processo di revisione, di pulizia e di depurazione. A volte ci vogliono mesi per comprendere l’esistenza di una parola o di una virgola in più in una frase. Questo processo di revisione è essenzialmente di sottrazione, di esclusione del superfluo, a beneficio dell’efficacia. Pubblicare un libro subito dopo averlo terminato è un errore gravissimo. La vera consapevolezza di ciò che si è fatto nasce trascorso il necessario riposo. Do tanto di me quando scrivo che, terminata la prima versione, sono così dentro da dovermi distanziare. È al ritorno che comincia il vero lavoro.
- Cosa sono per te verità e menzogna?
I territori della verità e della menzogna non hanno frontiere rigide. La verità e la menzogna non sono due punti lontani associati a un asse. Presentano sottigliezze molto peculiari che si avvicinano. Immagino e vedo la menzogna e la verità come due auto che girano intorno a una rotonda. Sono concetti circolari, che si superano a vicenda e che molte volte procedono fianco a fianco. La verità e la menzogna sono due armi pericolose, in quanto ostaggi di una lunga Storia di morale. La deviazione più insignificante dall’ordine morale, etico, religioso, ecc. può essere giudicata nel modo peggiore alla luce di ogni singola verità. Le perversioni che ne conseguono sono terribili, si tratta di una palude nel quale, senza saperlo, si corre il rischio di veder affondare un piede.
- Lavorando come traduttore editoriale, che effetto ti fa pensare di essere stato a tua volta tradotto?
Vedere la tua voce, definita dai meccanismi e dalle inclinazioni della tua lingua, trasposta in un altro spazio mediante mezzi distinti (ogni lingua ha la sua identità) dalla mano di un’altra persona induce in me felicità e curiosità allo stesso tempo. Come funzionerà quella frase con le soluzioni a disposizione nell’altra lingua? L’efficacia sarà la stessa? Considerando che la mia scrittura è ridotta al minimo, che vive molto degli spazi lasciati in bianco, vederla tradotta risveglia in me un certo interesse. So, ad esempio, che esistono costruzioni sintattiche in portoghese la cui ricchezza evocativa finisce per perdersi in inglese. E problemi identici si verificheranno in senso inverso. In quanto traduttore, cerco di ridurre queste distanze e mi auguro di ricevere lo stesso in quanto autore tradotto. La cosa più importante, tuttavia, è sapere che esistono mezzi per arrivare ad altri lettori attraverso quella grande arte che è la traduzione. C’è in essa qualcosa di magico. È la colla che tiene unito il mondo.
- In che modo differiscono il tuo approccio alla scrittura e alla traduzione? Quale ami di più e perché?
La scrittura e la traduzione sono una al servizio dell’altra. In entrambi i casi metto tutto il corpo, l’anima e la mente, ma nella traduzione esistono limiti, vincoli, restrizioni. Non bisogna mai cadere nella tentazione di permettere che la nostra voce entri nella voce dell’autore tradotto. Ciò può succedere, soprattutto quando esiste una vicinanza affettiva con l’opera che si traduce. Ad esempio, attualmente sto traducendo Ali Smith, un’autrice seduttiva, capace di creare paesaggi letterari che ti invitano (inconsciamente) a lasciare tracce della tua voce. Tradurre è trasformare questa inconsapevolezza in coscienza, senza mai lasciar addormentare l’occhio vigile. Il traduttore è sempre al servizio degli altri e ha l’obbligo di trasporre, il più fedelmente possibile, le proprietà autorali di chi traduce. Esiste già un punto di partenza e un punto di attivo e, nel cammino che ci unisce, il traduttore è la lente che registra il viaggio, senza mai allontanarsi dai piani.
Nella lettura, sono intero. Nella traduzione, sono parziale.
- A questo proposito, nel racconto “Dead can dance”, è un dubbio traduttivo a spingere il protagonista a trasferirsi in Inghilterra. Hai mai avvertito lo stesso senso di incomunicabilità e di incomprensione in prima persona?
Se non lo avvertissi, non sarei scrittore. Il combustibile della scrittura è tutto ciò che non si vede né si percepisce o si legge a occhio nudo. È ciò che sta dietro alle cose. Quando parlo e comunico, non posso esigere che l’altro conosca la storia che mi ha portato fino all’atto comunicativo. È dà questa frustrazione, che si converte in inquietudine, che nasce la parola scritta. La letteratura, a mio modo di vedere, deve essere sempre il rovescio della medaglia. O, per lo meno, deve partire da lì.
Tutti gli scrittori desiderano dire ciò che i rumori del quotidiano non permettono di dire. Comunicare il mondo solitario che tutti abbiamo in comune, ma che solo alcuni (per scelta o per caso) tentano di rivelare, con la parola, con l’immagine, con il suono. È un compito violento, che toglie molto, ma che risulta comunque ben più sopportabile che vivere in un “dubbio traduttivo”.
- Il filo conduttore di questi racconti è forse lo smarrimento del lettore, che si immagina uno svolgimento lineare della trama ma che viene puntualmente spiazzato. Hai voluto provocare il lettore spingendolo a pensare fuori dagli schemi?
Non scrivo mai con un’intenzione. Scrivo perché le dita hanno bisogno di premere i tasti. È semplicemente così, l’obbedienza a un impulso. Non so mai cosa nascerà, non so mai la direzione che prenderanno le cose, ogni passo è dato nell’incertezza, senza rete o protezione. Solo quando il testo è concluso inizio a sbrogliare le intenzioni che fino a prima erano rimaste nascoste. E in questo libro in particolare mi sono accorto che c’era qualcosa che ricordava i puzzle o, forse più precisamente, i film censurati. Una successione, di pezzi, o di fotogrammi, che insieme compongono differenti geometrie/architetture e paesaggi.
- I personaggi di questi racconti non hanno un nome, si sa poco di loro anche a livello fisico. Il tuo obiettivo era raccontare storie in cui tutti potessero identificarsi, senza associarle a determinati tratti fisici?
Sì. Ho un’estrema difficoltà nell’attribuire nomi e caratteristiche fisiche ai personaggi. Forse perché, quando lo faccio, sto attribuendo loro un passato, sto dando una direzione a una storia che non è ancora iniziata. Arrivando al limite, i protagonisti di questo libro non hanno passato, non hanno identità, non sono. Si limitano a succedere. E in questo universo senza nomi, né tempo, né geografia, il lettore avrà spazi di identificazione più ricchi, perché più aperti. C’è una certa generosità in questa assenza.
- C’è un racconto a cui sei particolarmente affezionato? Se sì, perché?
In verità non ho una particolare predilezione per alcun racconto. Ce ne sono però due che di tanto in tanto mi tornano in testa, anche se in modo vago: «Nota finale» e «Tetto». Non so perché, forse perché c’è in essi una dimensione che io stesso non comprendo interamente, come se custodissero una cosmovisione che è mia ma che non raggiungo, per quanto mi sforzi di stendere il braccio.
- Il titolo della raccolta si rifà all’idea che ci possono essere molti modi di mentire e che una menzogna può essere vista anche come una verità che assume un altro significato in base a come la si osserva. Da dove deriva il tuo interesse per questo tema?
Mi interessano le prospettive, i piani, gli angoli, la lente nella sua relazione con l’oggetto. Due persone poste davanti alla stessa cosa (fisica o astratta) vedono cose completamente diverse. Tutto questo è meraviglioso. È un prodigio. Una benedizione concessa all’Uomo. Non esistono due occhi uguali, non ci sono due verità uguali. Si mente dicendo la verità, si dice la verità mentendo. È in questo insieme fatto da più strati che si muovono le mie mani. Penso a Kubrick e a Bergman. Così distinti, ma alla fine capaci di produrre quella stessa materia essenziale che è la commozione: la commozione della scoperta da varie angolazioni. Kubrick ti si pianta nella mente e ti apre il cuore. Bergman ti si pianta nel cuore e ti apre la mente. Le linee sono le stesse, i canali sono identici, ma i punti di vista (le verità e le menzogne) sono diverse e producono immagini tanto lontane quanto vicine. È questo il punto. Lo spazio percorso tra chi vede e chi/o cosa è visto.
- C’è qualche aspetto che vorresti fosse colto dai lettori italiani e che ti auguri non sia andato perso con la traduzione?
Mi piacerebbe che i lettori italiani iniziassero a leggere il libro senza aspettative, con quante meno sovrastrutture possibile. In questo senso, non anticipo né consiglio nulla. Spero solo che il libro segua la sua naturale destinazione. Un lettore è sempre un lettore, in qualsiasi luogo del mondo. Se questa dimensione universale non dovesse andare persa nella traduzione (e confido che non sarà così) mi potrò dire molto soddisfatto.